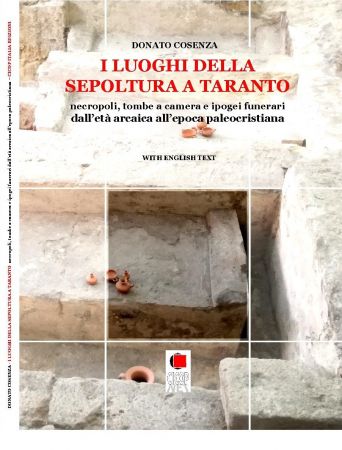
“I luoghi della sepoltura a Taranto – necropoli, tombe a camera e ipogei funerari dall’età arcaica all’epoca paleocristiana”
Pubblicazione del libro “I luoghi della sepoltura a Taranto – necropoli, tombe a camera e ipogei funerari dall’età arcaica all’epoca paleocristiana”, Edizioni CICOP Italia-onlus 2019 (70 pag. formato USA Letter, ISBN 978-88-943862-0-2, edizioni CICOP Italia)
Vendita on demand:
https://www.lulu.com/shop/search.ep?keyWords=donato+cosenza&type=
https://www.amazon.it/I-luoghi-della-sepoltura-Taranto/dp/8894386201/
Premessa
Il tema della sepoltura dei defunti è sempre stato estremamente caro al genere umano e ogni cultura umana, in qualsiasi epoca storica e a qualsiasi latitudine essa sia nata e si sia successivamente sviluppata, si è occupata di individuare – per i propri defunti – un luogo “sacro” destinato al riposo eterno.
Molteplici e dissimili sono i luoghi della sepoltura che l’uomo ha individuato e scelto e differenziate le tipologie di sepoltura che ha praticato nel corso della sua lunga storia.
Sembra che il primo a praticare riti funebri sia stato l’uomo di Neanderthal tra Europa, Asia ed Africa, mediante l’inumazione in fosse di forma ovale in cui inserisce un piccolo corredo funerario formato da oggetti di uso comune in pietra, piccole sculture, oltre a una certa quantità di cibo; le fosse vengono poi ricoperte con una lastra di pietra per tenere lontano gli animali selvatici. Preso atto della limitatezza dell’esistenza, gli uomini cominciano a credere nell’esistenza dell’aldilà governata da forze esterne. La comparsa del senso di trascendenza implica che la morte non sia più un fatto casuale e le sepolture – seppur “primitive” – diventano una vera e propria espressione di civiltà, coinvolgendo l’intera comunità.
In origine l’uomo dell’età della pietra comincia a utilizzare i tumuli per coprire le sepolture: la loro struttura, nel corso dei secoli, durante le successive età del rame e del bronzo, viene modificata e si trasforma in camere funerarie vere e proprie in cui il defunto riposa assieme ai suoi oggetti più cari e importanti. I tumuli possono essere definiti come delle collinette artificiali fatte di terra e roccia posti al di sopra delle sepolture – singole o multiple – a forma circolare o ellittica: è possibile trovare questi tipi di sepolture semplici in gran parte del mondo.
In Egitto, ai piedi delle piramidi, cioè alle tombe dei faraoni, incominciano a prendere corpo le necropoli, formate da tombe minori di aspetto più modesto e, in generale, molto meno monumentale delle complesse architetture delle piramidi; costruite secondo allineamenti regolari, ospitano i cortigiani, i favoriti e i funzionari del faraone. All’interno delle stanze in cui viene alloggiato il sarcofago raffigurante il defunto, vengono depositati gioielli, effetti personali del defunto e cibo. Lontano dalle zone delle piramidi e delle necropoli che si estendono intorno ad esse, si trovavano i depositi sepolcrali assai modesti del popolo, costituiti da sepolture nella nuda terra, con le salme rannicchiate e avvolte in semplici stuoie, corredate da semplici oggetti di uso quotidiano.
Nella civiltà etrusca, prima dell’VIII sec. a.C., è diffusa la sepoltura in semplici pozzi contenenti le ceneri del defunto (tombe a pozzo), sostituita ben presto dalla tomba a fossa destinata all’inumazione del cadavere. Un secolo dopo verrà introdotta la tomba a camera, struttura sepolcrale più complessa – di cui tratteremo ampiamente in seguito – che raggiungerà livelli architettonici e artistici molto importanti; in molti casi in essa si seppellisce un’intera famiglia, per cui spesso è formata da più camere collegate da corridoi e arricchite da corredi funebri preziosi a denotare lo stato sociale della famiglia. La sapiente tecnica costruttiva degli etruschi ha permesso che arrivassero fino a noi le splendide architetture delle coperture ad arco e a volta di mattoni e pietra di molte tombe a camera.
Per i greci – come per i romani – la sepoltura è estremamente importante tanto che il defunto che non ha avuto la possibilità di riceverla è destinato a vagare senza meta in una zona sotterranea al di fuori del regno dei morti. Per i romani, contrariamente all’usanza greca di seppellire i defunti anche all’interno delle città e anche senza un ordine prestabilito, entro i confini dell’urbe non devono esserci sepolture; le necropoli 1 infatti, si trovano al di fuori delle mura cittadine in aree nettamente distinte e delimitate. Alcune di esse sono progettate come veri e propri complessi architettonici e urbanistici, con attenzione all’assetto viario e all’orientamento, così come accadeva anche in alcune necropoli etrusche: basti pensare, tanto per citare le più importanti, a Tarquinia e a Cerveteri. Il rispetto per i defunti è talmente grande che si svolge una cerimonia funebre molto simile a quella che, in seguito, avrebbero adottato i cristiani.
Sin dagli albori del cristianesimo, i fedeli attendono la risurrezione dei morti, così come Gesù è risorto dopo la morte: per questo la Chiesa ha sempre preferito l’inumazione dei defunti, cioè la sepoltura nella terra, quale segno di attesa della risurrezione. Si sono adottate e si adottano ancora oggi la tumulazione in loculi o in sepolcri di famiglia ma la forma di sepoltura preferita rimane comunque l’inumazione. Non c’è mai stata, in realtà, la proibizione di bruciare i corpi dei defunti, cioè di praticare la cremazione, fino al divieto – palesato in tempi recenti – codificato nel Codice di Diritto Canonico del 1917. Il motivo di tale divieto risale al 1700 quando le logge massoniche anticlericali sostenevano la cremazione per negare la fede cristiana nella risurrezione dei morti; nel 1963, però, la congregazione del Sant’Uffizio la permise anche ai cristiani in quanto «come non tocca l’anima, e non impedisce all’onnipotenza divina di ricostruire il corpo, così non contiene, in sé e per sé, l’oggettiva negazione di quei dogmi». Perciò nell’attuale Diritto Canonico, promulgato nel 1983, si ribadisce che «la Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti», ma si sottolinea che essa «non proibisce la cremazione a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana».2
L’usanza dei primi cristiani di scavare fosse molto profonde, nelle quali deporre un cadavere sopra l’altro separati da una lapide, oppure fosse molto larghe in cui deporli uno accanto all’altro, viene sostituita dalle sepolture in tombe intagliate nella roccia, secondo la consuetudine ebraica, o costituite da un’unica camera sotterranea. Mancano ancora dei veri e propri cimiteri cristiani. Col tempo, le tombe diventano luoghi di ritrovo, soprattutto se in esse vi è deposto un martire.
A causa delle sempre più numerose conversioni al cristianesimo, oltre che per il desiderio di essere seppelliti più vicino possibile ai martiri, è necessario predisporre un’area per la sepoltura: il cimitero. Questo desiderio nasce anche dall’idea che il martire, avendo già raggiunto Dio, può intercedere per gli altri defunti al fine di ottenere la stessa beatitudine. I più famosi cimiteri sono le catacombe.
Le catacombe sorgono nel II secolo e vengono ampliate nel III secolo da professionisti chiamati fossores. Essi sfruttano terreni adatti, generalmente di tufo, che consentano uno scavo agevole e una tenuta sicura. Utilizzano pozzi già esistenti per intagliare le scale d’accesso che permettano di areare e illuminare parzialmente le gallerie, ma anche per portare in superficie il materiale scavato. In molti casi le gallerie delle catacombe formano una rete sotterranea molto articolata e fitta, come nel caso delle catacombe romane che contano una viabilità sotterranea di oltre 200 km.
Le tombe sono delle cavità intagliate nelle pareti delle gallerie (loculi), in cui il corpo del defunto viene adagiato e avvolto in un lenzuolo di lino. L’apertura si chiude con mattoni e pietre di marmo, alcune volte provenienti da tombe pagane, su cui vengono incise delle iscrizioni o dei segni di riconoscimento. Oltre ai loculi vi sono i cubicula per intere famiglie. In questo caso i loculi sono intagliati nelle pareti delle stanza o sul pavimento e si corredano di affreschi e iscrizioni.
Tombe ancora più elaborate sono le arcosolia, cavità a forma di sarcofago sormontate da nicchie a forma di arco. A seconda delle possibilità economiche della famiglia del defunto si utilizzano sarcofagi di marmo o terracotta.
Inizialmente, seguendo l’uso pagano, i cristiani fanno costruire accanto alle tombe una cella per i banchetti funebri, da celebrare negli anniversari del defunto. Il banchetto viene chiamato refrigerium. Attraverso esso si onora la memoria del defunto e si cerca di ottenere per lui intercessione presso Dio.
Col tempo il refrigerium viene soppresso e rimane solo la celebrazione dell’Eucaristia. La cella alcune volte viene modificata e ingrandita, divenendo una vera e propria Basilica, oppure incorporata in una chiesa cimiteriale più grande.
A differenza dei pagani, i primi cristiani non rimpiangono la vita, anzi, sono protesi verso il cielo. Nelle iscrizioni delle catacombe si leggono auguri di pace (pax tecum, in pace, cum angelis), o di vita (Viva in aeternum, in pace Dei, cum Christo). Spesso l’auspicio è di refrigerio (il Signore dia refrigerio al tuo spirito).
Le catacombe funzionano come cimiteri regolari fino all’inizio del V secolo, quando la Chiesa ritorna a seppellire esclusivamente sulla terra o nelle basiliche dedicate ai martiri più importanti. Con le invasioni dei barbari che saccheggiano anche le catacombe, la Chiesa decide, verso la fine dell’VIII secolo, di trasferire le reliquie dei santi e dei martiri nelle chiese di città per motivi di sicurezza.
Questa usanza persiste sino all’epoca barocca; la Chiesa oggi vieta tale uso, demandando ai cimiteri urbani tale prerogativa, come prescrive la legge italiana.
Data l’importanza che il culto dei morti e le credenze dell’aldilà hanno avuto attraverso i secoli, i complessi sepolcrali hanno costituito e costituiscono le più ricche fonti intorno alla civiltà, alla religione e alla vita privata degli antichi. Senza lo studio e l’esplorazione delle necropoli, l’archeologia sarebbe ancora molto lontana dalla ricchezza e dalla sicurezza dei risultati ottenuti.
(…)
Capitolo 2
2.1 – La Necropoli di via Marche
Nel periodo di massimo splendore urbanistico e architettonico, la città greca è divisa in Acropolis, Polis e Necropolis. L’Acropoli, la parte alta della città, con i suoi templi e i suoi edifici pubblici monumentali è situata ad est (l’attuale isola denominata “città vecchia”); procedendo in questa direzione si attraversa la Polis, la zona residenziale con l’Agorà, la grande piazza centro economico e commerciale della città; ancora più ad est si raggiunge la necropoli, la città dei morti che alloggiava le tombe dei defunti.
Data la conformazione morfologica del territorio tarantino, la città continua ad espandersi verso est, invadendo l’area occupata dalla Necropoli, cosicché le sepolture devono essere spostate più ad est, fino a raggiungere la cinta muraria.
La distribuzione delle sepolture quasi certamente rispetta due assi viari perpendicolari tra loro, uno in direzione nord–sud e uno est–ovest; quest’ultimo asse è identificabile con una vera e propria plateia(la “via larga” delle poleis greche). Come abbiamo rilevato, l’esistenza degli assi viari con molta probabilità è già presente nell’urbanistica della città arcaica.
Il percorso predisposto dalla Soprintendenza Archeologica per la visita della necropoli, realizzato con una passerella a “zig-zag” con orientamento nord-sud ed est-ovest e che ricalca gli assi viari dell’epoca arcaica, è impostato all’incirca alla stessa quota del piano di campagna delle tombe a camera ipogee dell’età classica ed ellenistica. Il percorso, inoltre, segue un ordinato criterio cronologico: infatti entrando da via Ugo De Carolis si incontra una prima zona di tombe a fossa dell’età arcaica, per poi procedere verso la zona occupata dalle tombe a sarcofago e quindi dalle tombe a camera ellenistiche, più vicine all’uscita del sito situata in corso Italia. Probabilmente l’attuale passerella in grigliato metallico, sopraelevata rispetto al piano delle tombe e poggiante su piedini metallici, dà un senso di provvisorietà e sicuramente potrebbe essere sostituita con una passerella in vetro o altro materiale trasparente più elegante e meno invasiva.
In questo straordinario sito archeologico si concentrano tre diverse tipologie di tombe:
· tombe a fossa, semplici tombe scavate nella terra o nella roccia, talvolta rivestite da lastre di carparo, il più delle volte caratterizzate da una copertura piana a doppio lastrone o, in alcuni casi, spiovente. Nel sito sono state ritrovate anche alcune tombe a fossa sprovviste di copertura o forse in origine con copertura lignea che col tempo si è deteriorata ed è andata perduta.
Utilizzate soprattutto durante l’età arcaica, sono destinate ai cittadini più poveri; ad ogni modo la loro costruzione si protrae sino all’età ellenistica, laddove la famiglia del defunto non aveva i mezzi per dedicare al proprio caro una più moderna tomba a sarcofago.
· tombe a sarcofago, sostanzialmente singole bare destinate ad ospitare un solo defunto, realizzate con un monoblocco di carparo; generalmente coperte con doppia lastra di pietra riproducente gli spioventi di un tetto; presentano un dente d’incastro tra la copertura e le pareti verticali. L’orientamento privilegiato dei sarcofagi è est-ovest, presumibilmente senza alcuna preferenza per la posizione del corpo.
· tombe a camera ipogea a pianta rettangolare, collocate nelle posizioni più privilegiate come nei pressi degli incroci degli assi stradali, spesso sopraelevate rispetto alle altre sepolture più modeste. Le otto tombe a camera ritrovate nel sito di via Marche sono l’espressione di appartenenza del defunto a una classe sociale elevata; sono accessibili attraverso un corridoio (dromos) a gradini o a scivolo, hanno pareti in parte scavate in parte costruite con blocchi regolari di carparo, intonacate e dipinte, e presentano all’interno il letto funebre (kline) scolpito nella roccia, decorato e dipinto. Il colore prevalente è il bianco, poi il blu, il rosso e l’ocra. Per volere della Soprintendenza Archeologica è stata ricostruita una camera sui resti di un dromos a gradini e di un kline. La ricostruzione ci mostra l’aspetto finale della tomba con l’intonaco e la coloritura delle pareti, il corredo funebre dei vasi ceramici e i piatti per le offerte di cibo; ci mostra, inoltre, la quota del piano di campagna della necropoli in età classico-ellenistica, circa tre metri al di sopra del piano di calpestio della tomba.
La costruzione delle tombe a camera si interrompe all’inizio del V sec. a.C. quando il regime aristocratico che governa la città viene sostituito da un nuovo governo democratico che, in nome di una nuova ristrutturazione culturale e urbanistica, vieta tutto ciò che è lussuoso, quindi anche la costruzione di tombe a camera.
Dopo circa un secolo dall’emanazione di tale divieto – durante il quale i più ricchi si “accontentarono” di seppellire i loro defunti in tombe a sarcofago finemente dipinte – il divieto viene abrogato e i tarantini ricominciarono a costruire “lussuose” tombe a camera. Le tombe a camera vengono dotate di una porta a saracinesca per la chiusura, in modo che non possano più essere riaperte.
Tra le otto tombe a camera ritrovate, tre di esse sono dipinte e sono collocate proprio all’incrocio tra uno degli assi stradali N-S e la più larga plateja; sono tra le poche ad essere caratterizzate dalla presenza di segnacoli funerari, di cui sono stati ritrovati alcuni frammenti in pietra. Due delle tre sono camere appaiate, costruite nel medesimo momento e destinate a membri della stessa famiglia: una delle due contiene due deposizioni, altre tre deposizioni sono collocate nell’altra camera.
La terza tomba a camera ospita quattro deposizioni di adulti. Secondo la tipologia dei monumenti funerari del III sec. a.C., il kline è costruito con blocchi riportati e rifiniti in loco con le testate modanate a rilievo e piedi a volute contrapposte, come, ad esempio, nella tomba a camera di piazza Pio XII, di cui tratteremo in seguito.
Le varie campagne di scavi che si sono succedute e che hanno riportato alla luce le attuali 140 tombe presenti nel sito – tombe maschili e femminili ma anche alcune tombe a fossa di bambini – hanno fatto riemergere non solo tombe ma anche fossette a destinazione agricola e due pozzi per l’acqua.
Un interessante studio pubblicato nel 1997 dall’Università di Bari (11) ha esaminato il materiale osteologico rinvenuto nella necropoli di via Marche: sul totale di 56 scheletri su cui è stato possibile effettuare l’analisi – 38 appartenenti a uomini e 18 a donne – è stata rilevata una statura media di cm 168 per i maschi e di cm 161 per le femmine e una discreta robustezza corporea. La frequenza dei decessi è del 14% nell’età infantile, del 7% nell’età giovanile, del 52% nell’adulta, del 17% nella matura e nel 7% dell’età senile. Lo studio evidenzia inoltre che le affinità genetiche dei tarantini in età classica si hanno con gli apuli e i sanniti più che con i greci.
(…)
