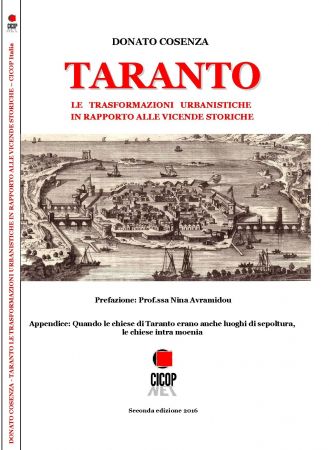
“Taranto – le trasformazioni urbanistiche in rapporto alle vicende storiche” II edizione
Pubblicazione della seconda edizione del libro “Taranto – le trasformazioni urbanistiche in rapporto alle vicende storiche”, con prefazione della Prof.ssa Nina Avramidou (92 pag. formato A4, ISBN 978-88-909116-8-2, edizioni CICOP Italia)
Vendita on demand su www.lulu.com (disponibile anche e-book)
Prefazione:
Parafrasando le parole di Benedetto Croce nella prefazione del libro di G. C. Speziale sulla “Storia Militare di Taranto negli ultimi cinque secoli”, Bari, Laterza, 1930, di frequente si prova un certo sospetto nei confronti dei libri che trattano di storia locale o limitata ai confini di una città, sovente giudicati frettolosamente di scarso interesse o di nessun valore per il riferimento ai contesti territoriali ridotti di cui tratta; tuttavia, non meno privi di interesse appaiono anche tanti libri di storia nazionale ed internazionale, a dimostrazione che la mancanza d’interesse e di valore è solo nella maniera e nella cura di esporre i fatti e non certo nella “scala” della trattazione.
L’autore di questo libro riesce a trasmettere ai suoi lettori il suo profondo amore verso questa città, sua città natale, che egli stesso ha definito “bella e dannata”, intrattenendoli con argomenti diligentemente e solidamente documentati.
Dopo un’attenta analisi della storia dell’architettura e dell’urbanistica di Taranto, costantemente rapportate alla vita della società locale, l’Autore ripercorre le fasi storiche della città dagli albori della sua civiltà alla crescita ed allo sviluppo di una delle più fiorenti città della Magna Grecia, dove, come egli stesso scrive, la monumentalità dei prospetti degli edifici e la ricchezza delle decorazioni ne ostentano la grandezza ed il potere economico. Dalla città arcaica alla conquista romana, dai periodi oscuri del medioevo alla qualità formale dell’architettura del ‘700, dai piani regolatori dell’800 allo sventramento fascista, dai piani di recupero e risanamento conservativo dello scorso secolo all’abbandono e al degrado della città vecchia oggi, questo testo ripercorre sia i momenti di grandeur che le fasi, spesso lunghe, di decadimento.
Lo stato di degrado in cui versa oggi la città vecchia devono necessariamente far riflettere sulla possibilità di rimediare urgentemente agli errori commessi in passato – errori commessi non solo dalla classe politica e dirigenziale, ma anche dalla stessa cittadinanza – e riportare Taranto sul podio delle eccellenze nazionali, avendone tutti i requisiti culturali.
Mi auguro che le indagini felicemente condotte sulla storia della “città dei due mari”, che conta duemilasettecento anni di storia, spronino l’Autore ad andare avanti nel suo percorso di esplorazione di questa suggestiva zona d’Italia, ancora poco conosciuta o mal conosciuta, che pur nella sua attuale decadenza affascina ancora oggi anche il visitatore distratto e frettoloso.
Nina Avramidou
Università degli Studi di Firenze
Presidente CICOP Italia-onlus.
(abstract)
La nascita di tante nostre città dell’Italia meridionale è collegata alla storia e alla mitologia della Grecia antica. Una di queste è Taranto. Fondata nel 706 a.C. da esuli spartani, diviene una delle più fiorenti città della Magna Grecia, dove la monumentalità dei prospetti degli edifici e la ricchezza delle decorazioni ostentano la grandezza ed il potere economico. Dalla città arcaica alla conquista romana, dai periodi oscuri del medioevo alla qualità formale dell’architettura del ‘700, dai piani regolatori dell’800 allo sventramento fascista, dai piani di recupero e risanamento conservativo dello scorso secolo all’abbandono e al degrado della città vecchia oggi, questo scritto ripercorre i momenti di grandeur e le fasi, spesso lunghe, di decadimento: le vicende della società e della politica tarantina, dell’urbanistica e dell’arte, sono attraversate da periodi di ripresa che si susseguono ad epoche di forte perdita di prestigio. Aspettando un nuovo rinascimento della “città dei due mari”…
Passeggiando per le strade dell’isola si è pervasi da un doppio sentimento, assai contrastante. Da un lato è fulmineo accorgersi di essere in un luogo dalle forti, peculiari valenze storiche ed artistiche, che sono un dato oggettivo. Dall’altro non si può non notare l’abbandono ed il forte degrado di una città con porte e finestre murate, coi vicoli perennemente puntellati, che vive precarie condizioni igieniche, non del tutto dissimili da quelle ricordate dai viaggiatori storici, dovute alla costante presenza di rifiuti per strada, all’interruzione dell’erogazione dell’acqua pubblica per molte ore al giorno, alle inadeguate reti fognanti.
Parafrasando il pensiero di Pierluigi Cervellati, espresso in una recente intervista, si può certamente asserire che negli anni ‘70 il centro storico di Taranto non ha colto l’attimo favorevole e la grande occasione del rilancio è andata perduta. L’occasione poteva essere il piano Blandino, che prevedeva (e prevede) un modello di recupero conservativo tale da avviare, contestualmente, il recupero sociale del centro storico.
Con i finanziamenti comunitari, arrivati nel quinquennio che va dal 2001 al 2005, sono stati effettuati restauri dei grandi contenitori, quali palazzi nobiliari e conventi – Ricordiamo Palazzo Pantaleo, Palazzo di Città, Palazzo Galeota, Palazzo Amati, il Convento di Santa Chiara, il Convento di San Francesco – quasi tutti adibiti ad uffici o sedi universitarie, come l’ultimo in lista, mentre nulla è stato fatto per la residenza: così, la sera, alla chiusura degli uffici e delle università, la città si spopola e rimane solamente una sensazione pregnante di abbandono, degrado, povertà.
Dal primo censimento della popolazione, effettuato nell’anno dell’unità d’Italia, si evince che la popolazione era allora di 24.528 residenti. Nel 1901 sale a 52.667 ed il trend cresce, fino agli anni del boom economico (o del miraggio), arrivando al massimo storico di 228.841 nel 1981. Da quel momento in poi l’andamento demografico assume il segno meno ed arriva, nell’ultimo censimento del 2011, a 200.154 residenti.
L’isola, dai problemi di sovrappopolamento degli anni ’50 e ’60 (quando contava quasi 20.000 abitanti) subisce un progressivo spopolamento: 10.000 abitanti nel 1975, 7.000 nel 1980, fino all’abbandono quasi totale dei giorni nostri (2.400 odierni).
La “molle et imbelle Tarentum”, come Virgilio la descriveva, è definizione ancora attuale e calzante, per una città che s’è lasciata scivolare addosso pestilenze, carestie e dominazioni straniere. Un’urbe sul cui territorio intellettuali ed artisti non sono mai mancati ma da cui, spesso se non sempre, hanno preferito partire. O piuttosto sono stati costretti a farlo, per esprimere la loro qualità e far conoscere il proprio genio, non solo in Italia ma nel mondo intero.
Momenti di grandeur e fasi, spesso lunghe (come la storia rammenta) di decadimento: le vicende della società e della politica tarantina, dell’urbanistica e dell’arte, sono attraversate da periodi di ripresa che si susseguono ad epoche di forte perdita di prestigio. Parrebbe evidente che il nemico da combattere non si trovi fuori la città ma sia, al contrario, profondamente radicato in essa. Ed abbia il nome di mentalità, mancanza di amministrazioni illuminate, oltre a carenza patologica di capitali ed infrastrutture.
Possiamo aspettarci un nuovo rinascimento tarantino che porti questa città, bella e dannata, a brulicare di turisti e visitatori, finalmente interessati alla sua antichissima cultura, figlia di una storia del tutto originale, che qui abbiamo appena accennato?
Possiamo aspettarci un nuovo rinascimento della città vecchia, in cui i grandi contenitori dei palazzi nobiliari settecenteschi e dei vasti conventi possano essere oggetto – questa volta simultaneamente al recupero ed alla razionalizzazione dell’edilizia più povera, rivolta verso Mar Piccolo – di un riuso intelligente, con la realizzazione di residenze per le nuove famiglie tarantine, e non solo?
Possiamo aspettarci un nuovo rinascimento dell’isola, in grado di trasformare le inestimabili risorse del patrimonio costruito in opportunità di riscatto sociale e morale, oltre che economico, convertendo quel che oggi è un punto di debolezza in autentico punto di forza?
Possiamo insomma aspettarci un nuovo rinascimento della città dei due mari?
