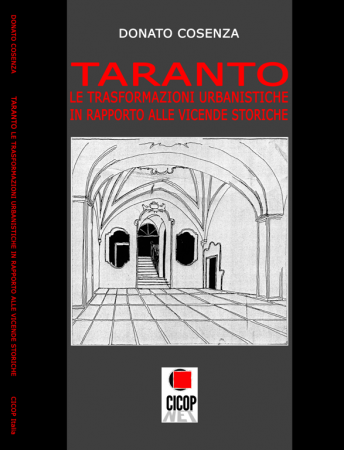
“Taranto – le trasformazioni urbanistiche in rapporto alle vicende storiche”
Pubblicazione del libro “Taranto – le trasformazioni urbanistiche in rapporto alle vicende storiche” (104 pag. formato A5, ISBN 978-88-909116-7-5, edizioni CICOP Italia) Vendita on demand su www.lulu.com (disponibile anche e-book)
(…)
CAPITOLO 6: ARCHITETTURA E URBANISTICA DEL NOVECENTO
L’amministrazione comunale del primo novecento mostra presto di non essere in grado di pianificare e controllare lo sviluppo urbanistico. Facendo i conti con le limitate disponibilità delle proprie casse, si limita a modesti interventi: “di fronte agli ostacoli finanziari, il poco sarà meglio del nulla e del poco bisogna accontentarsi”[1].
I venti di guerra, il nazionalismo e le ambizioni imperialistiche italiche contribuiscono però a far arrivare molto denaro pubblico, utilizzato per la militarizzazione della città; mentre si avvia il progetto di ampliamento dell’Arsenale e della rada di Mar Grande – ma anche dell’edilizia privata del borgo orientale – la popolazione cresce in maniera smisurata, fino a raggiungere i 103.000 abitanti nel 1921. Gli abitanti della città vecchia vivono in condizioni misere e disagiate.
La guerra comporta l’immigrazione dalle campagne, grazie alla crescente domanda di manodopera da parte dell’Arsenale e dei cantieri navali Tosi, di recente costruzione. Con la fine conflitto la municipalità ritorna in mano ai civili, tornano a casa i combattenti, si smobilitano i cantieri e si riduce il personale dell’Arsenale: comincia un nuovo periodo di crisi economica, caratterizzata dalla crescente disoccupazione e dall’inflazione, che dimezza le rendite della piccola borghesia urbana e contadina.
Ancora una volta, elusi i grandi temi economici, si riavviano le iniziative edilizie rivolte a strade, sistema fognario, illuminazione pubblica, risanamento della città vecchia e nuova; si aprono i cantieri per l’edilizia economica e popolare nei quartieri Tre Carrare, Solito e Corvisea, che danno ossigeno all’imprenditoria edile privata.
Si paventa anche la promozione di Taranto a capoluogo di provincia… e per questo è necessario dare una nuova immagine alla città: una veste moderna, con una griglia articolata di edifici pubblici e politico-amministrativi. A tale scopo nel 1920 il noto urbanista Giulio Tian viene chiamato a redigere un nuovo piano di ampliamento, ipotizzante uno sviluppo della città fino a 150.000 abitanti.
Il Tian critica ed abbandona la scacchiera, sinora utilizzata, e teorizza un’espansione a zone e diversificazione delle tipologie edilizie; il disegno della città viene ricondotto all’interno del dibattito urbanistico europeo, con una complessa rete viaria di penetrazione e di collegamento col borgo ottocentesco, doppia circonvallazione (interna ed esterna), reti del verde e parchi urbani collegati alla grande viabilità.
Il piano incontra molte difficoltà nell’approvazione e viene definitivamente messo da parte, a seguito delle osservazioni del Genio Civile, che critica l’immane spesa occorrente. Conosce poi una ripresa parziale grazie ad un comitato cittadino apposito, che approva la saturazione delle maglie ancora disponibili, per una espansione ridotta a soli 4.000 abitanti.
Dopo la marcia su Roma il regime fascista incita la ripresa edilizia che, effettivamente, si manifesta negli anni successivi al ’23. Nel centro storico vengono demoliti i conventi di San Giovanni e dei Celestini, con l’ipotesi di creare un’area archeologica intorno alle colonne del tempio greco riportate alla luce in piazza Castello, proprio a seguito della demolizione del convento dei Celestini.
Nella città ottocentesca (oggi definita Borgo Umbertino), cresce l’attività privata, con interventi di media e grande portata, spesso speculativi. Questi si concludono con il disegno del nuovo Lungomare di Ferdinando Bonavolta[2] – il quale, riprendendo lo schema del piano Tian, assegna il prevalere della destinazione direzionale.
Il crescente affollamento della Città Vecchia, col conseguente peggioramento della qualità della vita degli abitanti, spinge sempre più a proseguire l’ampliamento della città nuova: all’inizio degli anni ’30 Taranto si trasforma in un grande cantiere, che coinvolge sia la città vecchia sia la città nuova.
Il 7 settembre 1934 Mussolini visita ufficialmente la città, inaugurando il nuovo Palazzo del Governo sul Lungomare – progettato dall’architetto Brasini e considerato uno degli edifici più emblematici ed imponenti dell’era fascista nel mezzogiorno d’Italia – e dando “il primo colpo di piccone alla città vecchia”.
Il Bonavolta – accusato da molti di voler cancellare anche la memoria della città storica – accetta l’incarico del neonato Istituto Case Popolari di demolire le vecchie case fatiscenti dei pittaggi Turripenne e Ponte, per costruire nuove palazzine popolari; il progetto è corredato da un lungo viale alberato e da una nuova banchina per l’attività piscatoria; propone altresì l’ampliamento del mercato del pesce e di Piazza Fontana, oltre alla sistemazione di Piazza Castello e del suo “parco archeologico”. Nel Borgo la complessa mole di lavori coinvolge anche i prolungamenti di via Cesare Battisti, via Oberdan, via Dante, viale Virgilio nonché il Lungomare, utilizzando in parte gli elaborati redatti dal Tian dieci anni prima.
La nuova politica di espansione fascista prende corpo con la guerra d’Africa del 1935 e ciò riapre il dibattito sul potenziamento della base militare; superate le proposte di spostamento del Castello, di ampliamento del canale navigabile e della realizzazione di un nuovo canale navigabile a Porta Napoli, si avvia la fondazione di un nuovo Arsenale a Mar Grande, che rende superfluo l’ampliamento del canale esistente.
Durante la seconda guerra mondiale le sorti della città sono strettamente legate alla Marina, della quale è particolarmente orgogliosa d’ospitarne la flotta; ogni unità che entra ed esce dal porto militare viene salutata con scene di giubilo, in perfetto stile propagandistico fascista. La tragica notte dell’11 settembre 1940 la base navale viene bombardata e le illusioni dei tarantini, come dell’intera nazione, vacillano, mentre lo stato d’animo della gente rimane profondamente scosso.
Con la caduta del fascismo e nell’immediato dopoguerra si ripresentano i problemi di disoccupazione ed inurbamento massiccio, da cui riparte lo sviluppo produttivo e commerciale della città.
L’occasione per il rilancio economico arriva nel 1960 con la nascita del “Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Taranto” che ha tra i compiti quello di redigere il Piano Regolatore dell’area di sviluppo industriale, compito affidato alla TEKNE di Milano: nasce l’industria siderurgica, l’Italsider/ILVA. E dopo la redazione della variante al Piano Regolatore del Porto sorge anche il molo polisettoriale, che permetterà al porto di Taranto di balzare al terzo posto fra i porti italiani, dopo Genova ed Augusta, arrivando negli anni ‘80 al secondo posto.
Nel 1964 il Piano Territoriale prevede 5 comprensori individuati dal Piano di Zona 167; i maggiori tre comprensori sono individuati a nord di Porta Napoli (tra Tamburi e Paolo IV), gli altri due a sud (Taranto2 e Salinella).
L’edilizia civile si sviluppa rapidamente, grazie alla singola licenza edilizia ed all’abusivismo, creando una frattura sociale tra ghetti periferici, da un lato, ubicati su aree agricole non ancora raggiunte dall’urbanizzazione primaria e secondaria, e città storica e borgo ottocentesco, dall’altro; quest’ultimo già dagli anni ’50 è interessato da opere di demolizione e ricostruzione, che interessano anche Corso Due Mari ed il Lungomare.
In soli quattro anni la Bestat, una società per azioni con sede a Napoli, realizza un programma di costruzione di 800.00 metri cubi, un centro direzionale e commerciale tra i più grandi d’Italia, occupandosi anche delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria – in convenzione stipulata con il comune ed in variante al piano regolatore. Tra cui il moderno sottopasso che separa il traffico pedonale da quello veicolare.
Insieme al Ponte di Punta Penna Pizzone – progettato dall’Ing. Giorgio Belloni 15 anni prima della sua costruzione, avvenuta nel 1974 – il centro Bestat offre un aspetto più moderno alla città.
La “crescita civile ed economica” si riassume con i dati della incremento tumultuoso della sua popolazione: nel 1951 gli abitanti sono circa 170.000, nel 1961 sono 195.000, nel 1971 sono 227.000, nel 1981 sono 245.000.
L’occasione di rinnovamento e modernità giunge anche dall’edilizia religiosa, quando il vescovo Guglielmo Motolese accarezza l’idea di edificare una nuova Cattedrale nella zona orientale, visto che la Cattedrale di San Cataldo “rimaneva, per sua ubicazione, ormai avulsa dalla vita della comunità diocesana”[3]. Dopo la rinuncia di Luigi Nervi viene chiamato Giò Ponti il quale, nonostante l’età avanzata, accetta l’incarico di progettare quella Concattedrale che sarà tanto criticata, nel bene e nel male, dai tarantini. L’area idonea all’edificazione della Concattedrale, denominata “Gran Madre di Dio”, viene individuata all’estremo margine orientale dell’area urbanizzata. La facciata avrebbe costituito il fondale monumentale di via Dante, uno dei rettifili che portano al cuore della città storica, stabilendo un rapporto bipolare tra le due Cattedrali.
La ricerca sulla luce attraversa tutte le fasi progettuali: “la luminosità diffusa è congruente a un’idea di religiosità come serena partecipazione al mistero del sacro e alla sua presenza nella vita dell’uomo” (Irace 2009). “La luce consente di gerarchizzare lo spazio liturgico” (Zanzottera 2005), grazie al contrasto tra il pozzo luce sopra l’altare e l’illuminazione discreta sulle pareti laterali. Inizialmente la vela era stata pensata come “cupola rettangolare” aperta sul presbiterio, ma fin dal 1965 viene separata dallo spazio interno, che riceve invece illuminazione dalla parete vetrata del tiburio su cui si fonda la struttura reticolare della vela.
Se il volume esterno è rivestito di intonaco bianco, all’interno è il colore verde che conferisce unitarietà allo spazio e che avrebbe dovuto segnare un elemento di legame con l’ambiente esterno, dove un parco (non realizzato) avrebbe dovuto avvolgere la massa bianca della chiesa.
La storia dell’urbanistica tarantina subisce una svolta in conseguenza allo sviluppo del centro siderurgico dei primi anni Sessanta.
Per assorbire la pressione insediativa in città s’avvia un processo di urbanizzazione di difficile controllo e gestione; una delle direttrici di sviluppo si orienta verso sud-est, nell’istmo tra Mare Piccolo e Mar Grande, secondo una maglia viaria relativamente regolare, innervata sulla trama della città ottocentesca.
La Città Vecchia, oramai compressa tra le realtà urbane a nord e a sud dell’isola nonché sottoposta a forti interessi speculativi, è oggetto del piano di risanamento e restauro conservativo di Franco Blandino[4]. Il piano è accompagnato, durante tutta la stesura, da un fervente dibattito culturale, al quale partecipano Argan, Brandi, Dorfles, Palazzeschi, Zevi e altri nomi illustri, locali e nazionali. Il piano, sensibile al rispetto delle originarie tipologie ed orditure murarie, prevede l’intervento di risanamento igienico e conservativo per comparti esteso all’intera Città Vecchia, con un programma decennale di interventi. Intanto la densità della popolazione dell’isola si riduce notevolmente (molti sono i trasferimenti nei nuovi quartieri CEP e di edilizia economica e popolare), calando dai quasi 20.000 abitanti del 1961 ai 7.700 del 1979. Negli anni ‘70 e ‘80 il malessere culturale si estende anche alla politica e all’economia. L’Italsider/ILVA, dopo il raddoppio degli impianti, non riesce a ridurre i costi di produzione e non raggiunge livelli di concorrenzialità adeguati agli altri centri siderurgici europei: il progetto di modernizzazione e razionalizzazione non decolla e purtroppo non decollerà mai.
(…)
[1] Nicola Pellè, intervento presso il consiglio comunale di Taranto del 15 ottobre 1904
[2] Ferdinando Bonavolta, ingegnere capo dell’ufficio tecnico del comune, firmò il piano particolareggiato esecutivo per la costruzione del rettifilo piazza Fontana-stazione ferroviaria (1929) ed il piano del risanamento della città vecchia (1933)
[3] G. Motolese, “A voi parlerò di Dio, a Dio parlerò di voi”, Fasano 1990
[4] Franco Blandino, “La città vecchia di Taranto. Il piano per il risanamento e il restauro conservativo”, Bari 1974
